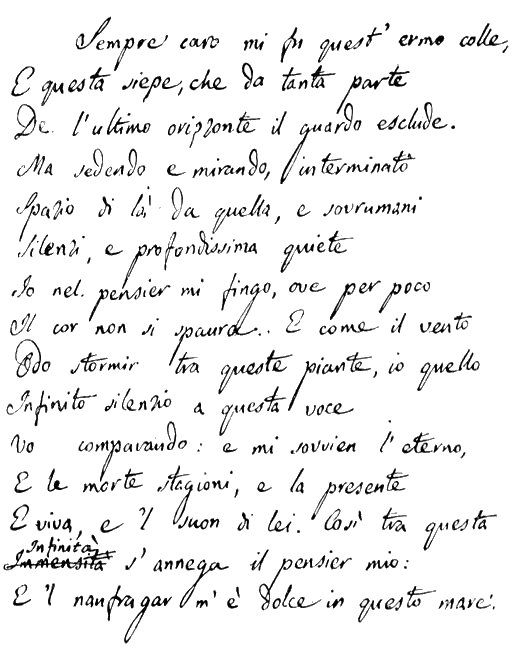di Ermes Dorigo.
Lo stimolo a questo scritto mi è stato dato dall’essermi imbattuto in una variante di Leopardi al verso 90 del Bruto Minore, la cui lectio definitiva è «solinga sede», mentre nell’autografo del 1821 troviamo come possibile scelta: «carnica, gelida, nevosa sede»: tale variante si trova segnalata nelle Concordanze dei Canti del Leopardi, di Antonietta Bufano (Le Monnier, 1969), e nei Canti di Giacomo Leopardi, commentati da lui stesso per cura di Francesco Moroncini (Sandron, 1917, ricordo che proprio al Moroncini si deve la prima edizione critica dei Canti – Cappelli, 1927 e poi 1961, con la pubblicazione anche delle varianti autografe del poeta e con la correzione delle manipolazioni operate da Antonio Ranieri nell’edizione definitiva in 41 poesie da lui curate per Le Monnier nel 1845).
Tale incontro non solo gratificò il mio amor proprio, avendo tempo fa, per rendere più mio l’amato poeta, tradotto gli endecasillabi sciolti de L’infinito nella parlata di Forni di Sopra, ma mi stimolò ad approfondire la percezione che il poeta ha del paesaggio montano e del significato metaforico-allegorico che a esso assegna nelle sue liriche. Nella poesia di Leopardi troviamo, infatti, che la contrapposizione/coesistenza tra “poesia di immaginazione “, propria degli antichi e dei fanciulli, e “poesia sentimentale”, riflessiva e meditativa propria della modernità, ha il suo correlativo in due paesaggi, “mediterraneo” l’uno, “nordico” l’altro, rivelatori, a livello antropologico, di due psicologie che s’intersecano e s’intrecciano proprio nella nostra cultura friulana di frontiera: qui, infatti, abbiamo sia i «nubiferii gioghi» dell‘Inno ai Patriarchi e i «ruinosi gioghi» di Alla primavera o delle favole antiche, sia il maggio odoroso di A Silvia, come pure nel Passero solitario, «primavera dintorno/brilla nell’aria, e per li campi esulta/sì ch’a mirarla intenerisce il core».
In generale Leopardi trasfonde la sua anima “classica” – serena, equilibrata e armonica – nel paesaggio solar-collinare, e la sua anima “romantica” – tumultuosa, tormentata e interiormente scissa – in quello tenebroso-montano; paesaggi spesso accostati oppositivamente con una connotazione negativa del secondo, come si evince chiaramente nei vv. 29-34 de II pensiero dominante: «da’ nudi sassi/dello scabro Apennino/a un campo verde che lontan sorrida/volge gli occhi bramoso il pellegrino».
Nel Bruto Minore, dove alla «Esperia verde» è contrapposta l’«Orsa algida», la tragedia di Bruto e il suo discorso disperato di rinuncia alla virtù prima del suicidio hanno come sfondo «l’atra notte in erma sede», e «i celesti odii» si materializzano nella furia del «nembo» e nel terrore del «tuon» in una natura divenuta ostile all’uomo moderno, che ha perso la primitiva e ingenua empatia con essa della «pura etade», «libera ne’ boschi», dove (Alla primavera) abitavano le mitiche Driadi e sui monti le ninfe Oreadi.
Tale opposizione raggiunge la massima evidenza nell’Ultimo canto di Saffo: «alle dilettose e care sembianze», alle «vezzose forme» della natura, da cui Saffo è respinta – «Placida notte, e verecondo raggio/della cadente luna»; «Bello il tuo manto, o divo cielo, e bella/sei tu, rorida terra»; «aprico margo», «il canto/ de’ colorati augelli», «de faggi/il murmure», l’ombra degli «inchinati salici», «candido rivo», «flessuose linfe», «odorate spiagge» – si contrappongono i suoi «disperati affetti», oggettivati in uno sconvolto paesaggio nordico: «Noi l’insueto allor gaudio ravviva/quando per l’etra liquido si volve/e per li campi trepidanti il flutto/polveroso de’ Noti, e quando il carro/grave carro di Giove a noi sul capo/tonando, il tenebroso aere divide./Noi per le balze e le profonde valli/ natar giova tra’ nembi, e noi la vasta/fuga de’ greggi sbigottiti, o d’alto/fiume alla dubbia sponda/il suono e la vittrice ira dell’onda».
Anche il tragico viaggio metaforico del «vecchierel» che si conclude in «abisso orrido, immenso» del Canto notturno di un pastore errante dell’Asia ha uno sfondo montano: «per montagna e per valle/per sassi acuti, e alta rena, e fratte/al vento, alla tempesta, e quando avvampa/l’ora, e quando poi gela/corre via, corre, anela/varca torrenti e stagni…» La montagna ha sempre un volto minaccioso o per le «atre nubi» o perché percossa e ferita dal «rombo/della procella», o anche funereo, come «il monte imbruna» de II tramonto della luna, o come nel Frammento LXL, che è parte della cantica giovanile, intitolata appunto Appressamento alla morte, o legato a simbologie di morte, come nel Passero solitario – «il Sol che tra lontani monti/dopo il giorno sereno/cadendo si dilegua, e par che dica/che la beata gioventù vien meno» -, il cui «solingo augellin» ci rimanda alla iniziale «solinga sede» montana, il cui finale è l’«arida schiena/del formidabil monte/sterminatore Vesevo» de La ginestra, dove la montagna – «l’altero monte» -, se pur in forma di vulcano, diviene l’allegoria della forza nemica e distruttiva della matrigna Natura, del vero della «frale» vita mortale.
Tale percezione metaforicamente negativa della montagna parrebbe essere incrinata dalle famose diadi: «quel lontano mar, quei monti azzurri» de Le ricordanze, e «quinci il mar da lunge, e quindi il monte» di A Silvia. A me pare che entrambi indichino dolore: il mare la perdita della fanciullezza, delle acque primordiali, e il monte, percepito non come altezza-misticismo ma come massa-minaccia-impedimento, quasi, cui bisogna fare violenza per liberarsene come ne La quiete dopo la tempesta: «Ecco il sereno/rompe là da ponente, alla montagna» – la durezza e il travaglio della maturità e del vero, slontanati catarticamente entrambi nell’indefinito (anche nei famosi versi de La sera del dì di festa troviamo tale rimozione psicologica: «… posa la luna, e di lontan rivela/ serena ogni montagna). Però, mentre per il mare il poeta riesce a rivelare una dolcezza anche all’interno dell’aridità de La ginestra («veggo dall’alto fiammeggiar le stelle/cui di lontan fa specchio/il mare») verso i monti, simbolo doloroso della verità della fatica di vivere e della sua sofferenza, tenta la dissolvenza: gli «azzurri monti» rivelano infatti un’intima pulsione di cancellare la verità della vita, assorbendoli nel colore del cielo e, quindi, annullandoli come tali.