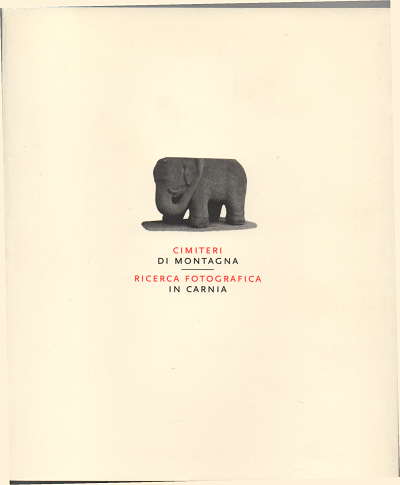di Ermes Dorigo.
Cimiteri di montagna è un libro pieno di vita, privo di tonalità luttuose; l’esistenza riceve un senso solo dal modo in cui ci si rapporta alla morte, come scrive Lev Tolstoj in Guerra e pace: “L’uomo non può nulla finché ha paura della morte. Tutto appartiene a chi non ha paura. Se non ci fosse la sofferenza, l’uomo non conoscerebbe i propri limiti, non conoscerebbe se stesso”; oppure, con parole di Salvatore Natoli ( L’esperienza del dolore, Feltrinelli): “La naturalità della morte è incentivazione alla vita, anzi pienezza del vivere.” Detto questo, senza divagare, ne ho già scritto, sulla fuga dalla morte e sull’eterno presente che caratterizza il nostro tempo, bisogna dire che ogni opera ‘significativa’ non appare casualmente, ma ha una sua motivazione intrinseca e giustificazione storica. Mi spiego. Verso la fine del 1700 e gli inizi dell’800 la riscoperta della identità nazionale di molti popoli europei si accompagna ad una corrente di poesia sepolcrale, che da Young a Gray culmina in Italia col carme di Ugo Foscolo, Dei sepolcri: la meditazione sulla tomba si propone non solo di restaurare il rapporto con la tradizione, ma di trovare dei significati, dei valori e delle direzioni da assumere per la vita, arrivando addirittura, come fa Foscolo, ad affermare che il culto dei morti sta, insieme al matrimonio, al diritto, alla religione, a fondamento della civiltà umana, che solo in tale maniera esce dallo stato ferino. Nell’epoca della globalizzazione e della necessità di mantenere la propria identità storico-culturale, questo libro fornisce una risposta analoga a domande simili: “la conservazione dei cimiteri non è un’ipotesi stravagante, in quanto anche i siti cimiteriali sono parte integrante del territorio e contengono significative testimonianze del passato, fonte indispensabile per l’interpretazione del presente”, e per una proiezione positiva verso il futuro, aggiungerei.
Gli autori – Patrizia Casanova, Patrizia Gridel, Marica Stocco, Adriana Stroili, Dino Zanier e foto di Romano Martinis – ci conducono in questo libro, raffinato per formato impaginazione e grafica, in uno stimolante viaggio attraverso la morte per la vita. È talmente denso, di testi immagini didascalie, che necessariamente sono costretto a trascurare aspetti anche importanti, per evidenziare soprattutto quelli coerenti con la tesi precedentemente formulata.
Dopo aver descritto i percorsi territoriali, seguiti nella ricerca, e aver fornito alcuni cenni storici sulle vicende dei cimiteri, un’attenzione particolare viene rivolta alle Lapidi superstiti, “le più antiche delle quali risalgono alla metà dell’Ottocento (la ricerca si protrae fino agli anni ’30 del 1900), si trovano di solito collocate lungo i muri perimetrali del camposanto, più raramente sulle pareti esterne di chiese e campanili e sui muretti di cinta dei sagrati. Antiche tombe e lapidi in terra si ritrovano ancora nei cimiteri delle pievi o in quelli dismessi. Sono questi i luoghi particolarmente ricchi di manufatti superstiti, poiché non si è resa necessaria la loro asportazione e distruzione per lasciare spazio alle nuove sepolture”.
Dopo aver analizzato Tipologie e materiali; Maestranze (“Nella maggioranza dei casi le lapidi sono opera di anonimi scalpellini che affiancavano questa ad altre produzioni non specializzate come il Velosio Bernardo di Ravascletto che negli anni Trenta si preparò, ancora in vita, la sua lastra tombale – «Rapito da Dio per farne un discepolo suo» – per assicurare a sé in morte quel segno distintivo che lui, modesto artigiano di umilissime origini, aveva sempre creato per altri. Si sono individuate però anche diverse opere firmate, alcune di pregevole fattura: un notevole altorilievo del 1915 di G. Mayer nel cimitero di Ligosullo – che richiama nella plastica opere del miglior liberty contemporaneo come quello di Bistolfi -, un cenotafio del 1871 a S. Giorgio di Comeglians, opera di un certo Pochero, che aveva lo studio di scultore a Firenze, e quelle provenienti dalla bottega dei Candoni di Terzo di Zuglio, di cui un bell’esempio del 1929, che raffigura un bambino vestito da marinaretto, è conservata nel cimitero di Paluzza. L’autore rappresentò il piccolo con l’abito che il padre emigrante gli aveva portato da New York e con il quale andava a scuola, suscitando la comprensibile ammirazione dei compagni, a cui volentieri prestava per un giretto il berretto e le scarpe con i lacci, a sostituire per un momento zoccoli e scarpez in un’effimera illusione di eleganza”);
Bambini (“La morte infantile è oggi un evento raro. Gli spazi riservati ai bambini nei cimiteri della Carnia sono quasi scomparsi, eppure sono alle volte ancora identificabili. Piccole tombe, spesso anonime, che però sono sopravvissute alle ferree leggi della rotazione e alla rimozione, segno di estrema pietà verso la più crudele delle sventure: la morte di un bambino. Già considerato in vita come essere innocente, alla morte viene simbolicamente rappresentato nel mondo puro ed eterno degli angeli. Si parla di angelico sonno, si rappresenta sulla piccola tomba l’angioletto racchiuso da due ali che disegnano un cuore, si raffigura l’edera tenace come il ricordo che non muore, si disegna il mazzo di fiori, simbolo di vita”).
A questo proposito un unicum è rappresentato dalla tomba con un elefantino in pietra, che si trovava nel cimitero vecchio della Pieve di Castoia a Socchieve. Secondo il compianto maestro Romualdo Fachin, l’elefantino – oggetto di trafugamenti ed ora custodito da un privato, anche se è andata persa la componente più artistica dell’opera, la bardatura – risalirebbe al 1900 circa, opera di Alessio Candotti (Lessio) di Lungis:” L’elefante, secondo la tradizione, costituiva il simbolo di un antico mito celtico. Tale animale, per quei popoli, aveva il compito di trasportare le anime dei bambini nei regni d’oltretomba. La credenza si rifaceva un po’ alle vecchie culture mediterranee. C’era però anche l’arcaico in questo simbolismo, che favoleggiava età perdute, i tempi di una idilliaca convivenza con la natura, con gli animali. L’affido di questi pargoli dopo il loro lacerante distacco dalla vita e dagli affetti ad un animale così pacato, quasi ieratico, composto e solenne come l’elefante, infondeva un senso di pace e di sicurezza, che si apriva alla speranza, in questo sia pur pagano raffronto con l’al di là”. (Il merito della conservazione di questa ed altre immagini del cimitero negli anni Sessanta è del fotografo Romano Martinis)
Si prosegue poi con l’analisi degli Epitaffi (“Se il cimitero è la rappresentazione dei vivi e non dei morti, tanto più questo appare evidente dalla lettura degli epitaffi), sui quali s’incentra il saggio di Marina Giovannelli, con una acuta e approfondita disamina delle differenze tra quelli riservati agli uomini e alle donne. Di grande stimolo, vitale appunto, è la sezione dedicata ai Simboli: “Molto ricco si è rivelato l’apparato di simboli che accompagna o si identifica con la stessa decorazione delle lastre tombali. È questo un aspetto di estremo interesse perché, anche ad una superficiale comparazione con l’oggi, questa simbologia di tradizione antichissima e lunghissima permanenza di significati sembra scomparsa, sostituita dalla ridondanza di apparati decorativi, che non rimandano ad altro significato se non a quello primario o ad attributi riferiti strettamente alla personalità del defunto (la montagna per chi amava andare in montagna, il cappello d’alpino…) amplificati dalla fotografia che non è più il solo volto ritratto in bianco e nero, ma più spesso è un’istantanea che riproduce una situazione, un frammento di vita. (La comunicazione insomma è strettamente individuale e rischia di terminare quando il circuito comunicativo defunto-sopravvissuto si interrompe)”. Troviamo i simboli di status, che ricordano l’attività svolta in vita dal defunto ma non hanno particolare significato allegorico: il calice o la particela, il breviario o la stola per i sacerdoti; il serpente di Esculapio per il farmacista; l’accetta e il cavalletto per il «boscaiolo capo»; raffigurazioni collegate a principi ideologici o etici: le mani unite, che rimandano a ideali di unità, fedeltà ed alleanza, potevano ricordare l’appartenenza a Società di Mutuo Soccorso; la squadra incrociata con il compasso, ma anche la cazzuola ed altri strumenti di derivazione muratoria, sono simbologia massonica. Forme vegetali e motivi floreali sono largamente utilizzati con significati simbolici più o meno evidenti: la ghirlanda di fiori ripropone la forma ciclica della vita eterna; l’edera rappresenta l’attaccamento alla vita; il papavero, ed in particolare le sue capsule, rappresenta il sonno, il sonno eterno e dunque la morte; il crisantemo (che entra nella moda funeraria intorno alla metà dell’800) simboleggia la riflessione (il suo nome orientale “chu” significa “attendere, soffermarsi”); il giglio, che nel cristianesimo è immagine dell’amore puro e virginale, nel simbolismo popolare rappresenta ancora la purezza, ma anche la “pallida morte”; con frequenza appare anche la rosa, soprattutto in festoni e ghirlande, che sulle tombe diventa il simbolo dell’amore che sopravvive alla morte e della rinascita; le foglie di alloro sempreverde, infine, erano considerate nel primo cristianesimo simbolo della vita eterna, dischiusa dall’avvento redentore di Cristo.
La clessidra rimanda l’immagine del tempo che passa; fiaccole, candele e fiammelle la nuova vita eterna; l’àncora, che nella prima età cristiana, per la sua forma a croce, venne utilizzata come simbolo mascherato della redenzione, rappresenta un elemento di stabilità e sicurezza e perciò si trasforma in simbolo di fede e speranza; la colonna spezzata, il teschio con le tibie incrociate e il libro aperto della vita simboleggiano la conclusione dell’esistenza terrena; le ali rimandano all’appartenenza alla sfera celeste, al sollevarsi al di sopra del mondo terreno, al volo, raffigurato dal cerchio con le ali; Alfa e Omega in alcune lapidi sostituiscono la dicitura “nato” e “morto”: inizio e fine dell’esistenza: Alfa e Omega sono la prima e l’ultima lettera dell’alfabeto greco ideato, secondo la leggenda, dalle tre Parche, le dee del destino; la torre fortificata protegge dall’assalto del male e rappresenta un rifugio sicuro, analogamente alla fede. Infine animali simbolici: il serpente nella forma di Oroboros, serpente che si morde la coda, a rappresentare la ciclicità, “l’eterno ritorno”; pavoni: nel Cristianesimo delle origini la carne del pavone era considerata incorruttibile (simbolo del Cristo nel sepolcro) e questo animale, che perde le penne della coda per rimetterle a primavera, rappresentava il rinnovamento e la resurrezione; la farfalla, simbolo della trasformazione, del futuro: nella tradizione popolare, non solo carnica, la farfalla, che rappresenta l’anima del defunto ancora vagante sulla terra, è un elemento simbolico molto radicato. Una leggenda, raccolta ad Illegio da Novella Cantarutti, narra di un uomo rimasto vedovo da poco che, intento a lavorare nel prato, vide una farfalla svolazzargli intorno: «Se sei la mia sposa avvicinati. Altrimenti vattene via!». E la farfalla con un breve volo si posò sulle sue labbra… Insomma, un libro – arricchito da un conclusivo ampio saggio di Giorgio Ferigo – tutto da guardare e da leggere.